Amiche motocicliste, vi vorrei far conoscere una rider davvero speciale. Mi è venuta in mente leggendo questo post di Wizzly.
E ho pensato che, fra tutte le persone che girano il mondo in moto, che ho conosciuto o di cui ho sentito parlare, Lois Pryce - detta "Lois on the loose" dal titolo del suo blog - è quella che ammiro di più.
Vi mostro subito delle foto tratte dal suo sito, per farvi capire di che pasta è fatta, e poi riprendiamo il discorso















La mappa che vedete mostra il percorso da lei fatto in soli 4 mesi nel 2006 con un enduro da 250cc. IN SOLITARIA.
Mi permetto di commentare un'immagine, anche se direi che si commentano tutte da sole: pensate soltanto che cosa possa significare per una ragazzina come quella che è salita sulla moto, nell'ultima foto, nel vedere una donna come Lois che viaggia da sola. Che forza dirompente possa avere nell'immaginario di donne che in molti dei Paesi da lei attraversati sono ancora soggette all'infibulazione e ad altri riti e usanze di sottomissione all'uomo.
Qui di seguito riporto il suo racconto di una tappa in Angola. Ricordo di averla vissuta "in diretta", raccontata poche settimane dopo che le era capitata. La traduzione è mia, l'originale lo trovate qui:
Link a pagina di Horizonsunlimited.com
Citazione:
Mi avevano detto che le strade in Angola erano in condizioni disastrose, dopo 25 anni di guerra, ma avevo già smesso da tempo di dar retta alle assurde storie “sulla strada che mi aspettava più avanti”. Sapevo che c’era sempre un solo modo per scoprire come stavano le cose, ed era quello di andarci. Perciò, dopo aver superato il confine alle tre del pomeriggio, mi diressi verso le montagne dell’Angola, determinata a sfruttare ogni raggio di luce diurna, ma alle cinque e mezza del pomeriggio ero riuscita a percorrere appena 80 km ed ero già al crepuscolo. La strada dal confine non era altro che una pista sconnessa e pietrosa che serpeggiava tortuosamente su e giù per le montagne. Gran parte di essa era stata dilavata dai recenti diluvi della stagione delle pioggie, e gigantesche pozzanghere spezzavano la pista, abbastanza profonde da obbligarmi a entrarci dentro a piedi per essere sicura che non inghiottissero la mia moto. Grazie ai campi minati, era fuori discussione la possibilità di accamparsi nella foresta perciò, appena scese l’oscurità, la mia unica possibilità rimase quella di farmi vedere in uno dei piccoli accampamenti lungo la strada e chiedere il permesso di piantare la mia tenda.
Affidai la scelta del villaggio salutando con la mano i locali una volta superati, e osservando le loro reazioni. In prossimità di un gruppetto di piccole costruzioni di mattoni di fango ottenni tutto un gran sbracciare, sorridere e salutare da ciascun abitante, perciò feci una rapida inversione a U e lessi ad alta voce la frase fatta del mio frasario in Portoghese: “Potrei accamparmi qui stanotte?”. Mi accolsero calorosamente e con molto interesse, compreso un gentile camionista di nome Sabe, anche lui in procinto di trascorrere la notte lì. Fortunatamente parlava francese, e una volta rotto il ghiaccio non perse tempo a passarmi un libretto religioso, spiegandomi che era seguace di una chiesa evangelica americana. Feci in modo di dormire qualche ora, nonostante intorno alla mia tenda ci fosse un gran trambusto di maiali e capre, e il mattino seguente alle sei e mezza ero già per strada.
Come venne fuori in seguito, tutto quello che avevo sentito circa le strade dell’Angola non era vero. Era molto peggio. Stavo correndo contro il tempo – se volevo farcela a raggiungere il confine con la Namibia prima che mi scadesse il visto, avrei dovuto percorrere dai 300 ai 500 km al giorno in un miscuglio di fango, allagamenti, scalate su roccia e discese, aspre torbiere, piste di sabbia, asfalto fracassato e elefantiache pozze d’acqua che avrebbero inghiottito un Tir.
Come se non bastasse, la stagione delle pioggie era in pieno corso e ogni mattina dovevo rimettermi calze e stivali, ancora fradici dal giorno prima, e immergermi nuovamente nella pioggia che grondava da un cielo nero illuminato soltanto dai fulmini che scoccavano intorno a me. I miei progressi erano terribilmente lenti, e quasi tutti i giorni mi trovavo a infrangere la regola d’oro e guidare di notte, nella speranza di fare a tempo a raggiungere un villaggio dove trovare un posto dove sostare e trovare un boccone di cibo.
Era senza dubbio la parte più difficile del mio viaggio, fino ad allora. Guidai ogni giorno dall’alba al tramonto, fermandomi solo per riempire il serbatoio o per i bisogni fisiologici, che erano di per sé complicati dato che lungo le strade era risaputo che c’erano le mine, e quindi era impossibile mettersi dietro a un albero. La mia unica chance era quella di aspettare che la strada fosse libera e nascondermi semplicemente dietro alla moto, facendo attenzione ad eventuali veicoli in arrivo. Ero diventata talmente ossessionata dal percorrere chilometri, che in un’occasione mi scoprii a far pipì dietro alla moto mentre mangiavo una banana, per risparmiare minuti preziosi. Quando si dice multi-tasking! Ma la miseria della pioggia, del fango e della guida ininterrotta continuò e dopo pochi giorni ero lurida, constantemente fradicia e assolutamente esausta.
Quando non mi facevo pena da sola, provavo pena per i poveri Angolani. La guerra aveva spazzato via il loro Paese. Ogni città era bombardata; la gente viveva ancora in case mezze crollate, e le mura di ciascun edificio erano crivellate da colpi d’arma da fuoco. Le strade e le ferrovie erano praticamente distrutte. Carri armati abbandonati giacevano lungo la strada e i bambini giocavano con i proiettili nel fango. Così non riuscivo a spiegarmi come il popolo angolano potesse essere la gente più piacevole che io avessi mai incontrato in Africa. Ovunque mi fermassi ero accolta con un sorriso amichevole, talvolta con un tentativo di saluto in inglese, ma sempre con calore e interesse genuini. Non vi era traccia della ressa e di quei tentativi di truffa o di richiesta di denaro che avevo incontrato in altri Paesi africani. E’ proprio il caso di dire che il fango, il sudore e le lacrime dell’andare in moto erano resi sopportabili dallo straordinario popolo angolano.
Trovare la strada si rivelava problematico. C’erano pochi cartelli stradali, e di quelli rimasti molti erano stati ridotti a brandelli dai proiettili. In un tardo, buio e piovoso pomeriggio, stavo guidando lungo quella che una volta era una strada asfaltata, e mi imbattei in una biforcazione imprevista. A sinistra, la strada mostrava quello che rimaneva dell’asfalto e si addentrava nella foresta. A destra invece si presentava un’alternativa davvero poco attraente: era una pista di terra, tutta buche e pozzanghere; anzi, era proprio sommersa da 30 cm di torrente. Le recenti piogge l’avevano praticamente trasformata in un fiume impetuoso. Mi fermai a pensare e ripensare, incerta su quale via scegliere. Non c’era nessuno in giro cui chiedere, ma potevo vedere delle tracce di pneumatici uscire dal fiume. Dall’altro lato, quello che rimaneva dell’asfalto suggeriva quale fosse il vecchio tracciato della strada ed era questa che, in corrispondenza della biforcazione, era stata segnalata con le consuete pietre miliari ufficiali dipinte in bianco e rosso. Sembrava dunque la strada più promettente perciò mi avviai speranzosa lungo quest’ultima, sobbalzando lungo la superficie accidentata. Ma dopo poche centinaia di metri, non so perché, ebbi la sensazione di avere preso la strada sbagliata.Decisi di girare la moto e tornare indietro all’incrocio e pensare ancora. Feci un’ampia inversione a U in mezzo agli alberi e intorno a una delle pietre miliari. Appena completata l’inversione, con la coda dell’occhio mi accorsi che c’era un scritta sbiadita sulla pietra e, sciaguratamente, il disegno di un teschio con le ossa incrociate. Mi fermai e guardai più da vicino. Trasalii quando lessi le parole che vi erano scritte: “Pericolo! Mine”. Il mio sesto senso mi aveva detto giusto: ero appena entrata in un campo minato...

Affidai la scelta del villaggio salutando con la mano i locali una volta superati, e osservando le loro reazioni. In prossimità di un gruppetto di piccole costruzioni di mattoni di fango ottenni tutto un gran sbracciare, sorridere e salutare da ciascun abitante, perciò feci una rapida inversione a U e lessi ad alta voce la frase fatta del mio frasario in Portoghese: “Potrei accamparmi qui stanotte?”. Mi accolsero calorosamente e con molto interesse, compreso un gentile camionista di nome Sabe, anche lui in procinto di trascorrere la notte lì. Fortunatamente parlava francese, e una volta rotto il ghiaccio non perse tempo a passarmi un libretto religioso, spiegandomi che era seguace di una chiesa evangelica americana. Feci in modo di dormire qualche ora, nonostante intorno alla mia tenda ci fosse un gran trambusto di maiali e capre, e il mattino seguente alle sei e mezza ero già per strada.
Come venne fuori in seguito, tutto quello che avevo sentito circa le strade dell’Angola non era vero. Era molto peggio. Stavo correndo contro il tempo – se volevo farcela a raggiungere il confine con la Namibia prima che mi scadesse il visto, avrei dovuto percorrere dai 300 ai 500 km al giorno in un miscuglio di fango, allagamenti, scalate su roccia e discese, aspre torbiere, piste di sabbia, asfalto fracassato e elefantiache pozze d’acqua che avrebbero inghiottito un Tir.
Come se non bastasse, la stagione delle pioggie era in pieno corso e ogni mattina dovevo rimettermi calze e stivali, ancora fradici dal giorno prima, e immergermi nuovamente nella pioggia che grondava da un cielo nero illuminato soltanto dai fulmini che scoccavano intorno a me. I miei progressi erano terribilmente lenti, e quasi tutti i giorni mi trovavo a infrangere la regola d’oro e guidare di notte, nella speranza di fare a tempo a raggiungere un villaggio dove trovare un posto dove sostare e trovare un boccone di cibo.
Era senza dubbio la parte più difficile del mio viaggio, fino ad allora. Guidai ogni giorno dall’alba al tramonto, fermandomi solo per riempire il serbatoio o per i bisogni fisiologici, che erano di per sé complicati dato che lungo le strade era risaputo che c’erano le mine, e quindi era impossibile mettersi dietro a un albero. La mia unica chance era quella di aspettare che la strada fosse libera e nascondermi semplicemente dietro alla moto, facendo attenzione ad eventuali veicoli in arrivo. Ero diventata talmente ossessionata dal percorrere chilometri, che in un’occasione mi scoprii a far pipì dietro alla moto mentre mangiavo una banana, per risparmiare minuti preziosi. Quando si dice multi-tasking! Ma la miseria della pioggia, del fango e della guida ininterrotta continuò e dopo pochi giorni ero lurida, constantemente fradicia e assolutamente esausta.
Quando non mi facevo pena da sola, provavo pena per i poveri Angolani. La guerra aveva spazzato via il loro Paese. Ogni città era bombardata; la gente viveva ancora in case mezze crollate, e le mura di ciascun edificio erano crivellate da colpi d’arma da fuoco. Le strade e le ferrovie erano praticamente distrutte. Carri armati abbandonati giacevano lungo la strada e i bambini giocavano con i proiettili nel fango. Così non riuscivo a spiegarmi come il popolo angolano potesse essere la gente più piacevole che io avessi mai incontrato in Africa. Ovunque mi fermassi ero accolta con un sorriso amichevole, talvolta con un tentativo di saluto in inglese, ma sempre con calore e interesse genuini. Non vi era traccia della ressa e di quei tentativi di truffa o di richiesta di denaro che avevo incontrato in altri Paesi africani. E’ proprio il caso di dire che il fango, il sudore e le lacrime dell’andare in moto erano resi sopportabili dallo straordinario popolo angolano.
Trovare la strada si rivelava problematico. C’erano pochi cartelli stradali, e di quelli rimasti molti erano stati ridotti a brandelli dai proiettili. In un tardo, buio e piovoso pomeriggio, stavo guidando lungo quella che una volta era una strada asfaltata, e mi imbattei in una biforcazione imprevista. A sinistra, la strada mostrava quello che rimaneva dell’asfalto e si addentrava nella foresta. A destra invece si presentava un’alternativa davvero poco attraente: era una pista di terra, tutta buche e pozzanghere; anzi, era proprio sommersa da 30 cm di torrente. Le recenti piogge l’avevano praticamente trasformata in un fiume impetuoso. Mi fermai a pensare e ripensare, incerta su quale via scegliere. Non c’era nessuno in giro cui chiedere, ma potevo vedere delle tracce di pneumatici uscire dal fiume. Dall’altro lato, quello che rimaneva dell’asfalto suggeriva quale fosse il vecchio tracciato della strada ed era questa che, in corrispondenza della biforcazione, era stata segnalata con le consuete pietre miliari ufficiali dipinte in bianco e rosso. Sembrava dunque la strada più promettente perciò mi avviai speranzosa lungo quest’ultima, sobbalzando lungo la superficie accidentata. Ma dopo poche centinaia di metri, non so perché, ebbi la sensazione di avere preso la strada sbagliata.Decisi di girare la moto e tornare indietro all’incrocio e pensare ancora. Feci un’ampia inversione a U in mezzo agli alberi e intorno a una delle pietre miliari. Appena completata l’inversione, con la coda dell’occhio mi accorsi che c’era un scritta sbiadita sulla pietra e, sciaguratamente, il disegno di un teschio con le ossa incrociate. Mi fermai e guardai più da vicino. Trasalii quando lessi le parole che vi erano scritte: “Pericolo! Mine”. Il mio sesto senso mi aveva detto giusto: ero appena entrata in un campo minato...

Buona strada a tutte le motocicliste del mondo.
Daniele



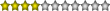

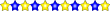










 )
)



